Recensione di Valerio Macagnone, segretario ESC (2020-2021)
“Non sarai tanto ingenuo da credere che viviamo in una democrazia, vero Buddy? È il libero mercato.”
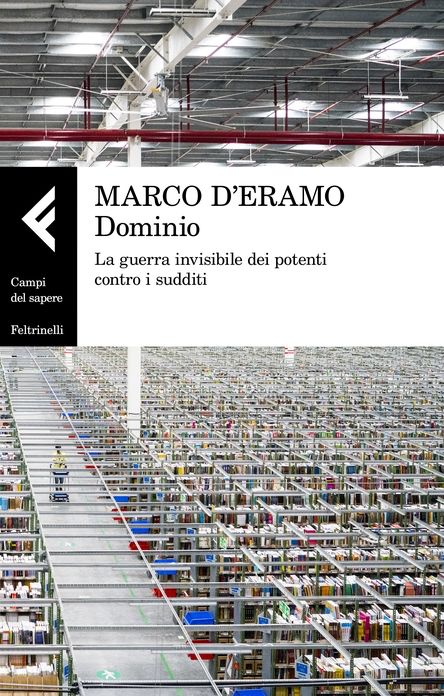
L’esito della rivoluzione neoliberale può essere perfettamente compreso alla luce di questa battuta di Gordon Gekko nel film “Wall street” di Oliver Stone. Un esito che nasce da una storia abilmente narrata con la spinta suggestiva di nuove idee e di parole d’ordine vecchie e nuove, con la capacità strategica di usare a proprio vantaggio le elaborazioni teoriche avversarie, con la capacità di camuffamento verbale e con la forza finanziaria e mediatica di plasmare un immaginario collettivo che, in preda all’amnesia permanente dell’evoluzione storica della democrazie occidentali, non possiede gli strumenti culturali per poter operare i paragoni tra le diverse fasi della storia del pensiero umano e dei poteri costituiti. Marco d’Eramo, nel suo ultimo lavoro, mette in evidenza la forza delle idee, la straordinaria macchina di egemonizzazione del pensiero globale, ovvero la forza necessaria di legittimazione dei poteri statuali che operano nella nostra contemporaneità che se da un lato, intonano le dolci note della liberaldemocrazia nelle sue forme istituzionali e nell’esaltazione dell’individualità dei singoli, dall’altro lavorano incessantemente per forgiare la mente e imbolsire il carico di vita gregaria dell’Homo consumericus di cui il genio acuminato di Frank Zappa tesseva le “lodi”: “Il nostro sistema scolastico cresce ragazzi ignoranti e lo fa con stile: ignorantoni funzionali. Non forniscono loro gli elementi per studiare la logica e non danno alcun criterio per giudicare la differenza tra il bene e il male in qualsiasi prodotto o situazione. Vengono preparati per funzionare come macchine acquirenti senza testa, a favore dei prodotti e dei concetti di un complesso multinazionale che per sopravvivere ha bisogno di un mondo di fessi.”
La storia degli 8248 “think tanks” ovvero degli apparati ideologici che fungono da serbatoi di pensiero e la loro azione combinata coi finanziamenti delle fondazioni (Olin, Bradley, Heritage, Koch, ecc.) che con le loro raccomandazioni hanno influenzato l’azione politica di una ampia fetta della politica conservatrice a stelle e strisce dagli anni ’50 in poi, è la storia di una controrivoluzione che, al campanello d’allarme del comunismo sovietico e della sua poderosa forza d’ispirazione nelle democrazie semi-sovrane dell’Europa post-bellica, ha reagito con studio, pazienza e progressivo infiacchimento delle forze protagoniste dell’avanzamento socialdemocratico. L’impressionante movimento di denaro che ha sconvolto la democrazia statunitense agevolando e sostenendo le teorie neoliberiste negli ambienti accademici e mediatici, è un movimento che interessa e influenza la politica occidentale con il preciso scopo di instillare la statofobia presso gli ambienti culturali di rilievo onde poterne neutralizzare la capacità di influenza progressiva e riconfigurare i poteri pubblici verso nuovi fini (accumulazione di capitale e redistribuzione in senso regressivo). Uno Stato minimo e forte nella misura in cui la sua azione è diretta alla tutela degli interessi dominanti. Naturalmente il “dominio” aveva bisogno delle sue leggi, ma soprattutto aveva bisogno che queste leggi fossero ammantate da un’aura di imparzialità scientifica e di apparente impermeabilità alle ideologie. In definitiva, l’epoca della restaurazione neoliberale doveva apparire post-ideologica e lontana dalle zavorre del “pensiero”: “È quindi un’ideologia che, al pari di tutte le ideologie, si presenta come non-ideologica, a-ideologica, scientifica, a colpi di equazioni e formule matematiche.”[1]È un dominio che applica l’analisi costi-benefici sia ai rapporti economici, sia ai rapporti sociali, e che sperimenta una rivoluzione antropologica in cui la società è vista come un immenso gioco non cooperativo in cui gli individui-agenti razionali hanno come solo scopo la massimizzazione dei profitti.
La rivoluzione (da “revolutio” che indica il moto di ritorno di un pianeta alla sua posizione d’origine) dunque necessitava di nuovi dispositivi culturali e, nello stesso tempo, di un certo rigurgito di anti-democraticismo che rievocasse taluni aspetti retrivi dello Stato liberale, dei suoi schemi concettuali e dei suoi corollari di visione censitaria del vivere sociale, e nello stesso tempo se ne discostasse generando nuovi paradigmi come il target ideale della libera concorrenza e del governo per il mercato. Una rivoluzione invisibile, lontana dalla percezione collettiva che nel frattempo è stata anestetizzata dagli aspetti più teatrali e risibili dei mantra neoliberisti (il “get rich or die tryin’” del self-made man) e che ha introiettato il retroterra culturale di questo dominio alla stessa stregua dell’accettazione di una legge naturale. Dunque, negli States, mentre Christopher Lasch, autore de “La cultura del narcisismo”, organizzava convegni di divulgazione del pensiero di Antonio Gramsci dando un’originale interpretazione del populismo (“Il populismo è la voce autentica della democrazia”), d’altra parte, e con intenti finalisticamente opposti a quelli di Lasch, Michael Joyce, l’attivista conservatore a capo della Olin Foundation, tesaurizzava il pensiero gramsciano sull’egemonia finanziando l’accademico Alan Bloom come testa di ponte del pensiero conservatore/neoliberale all’interno dell’Università di Chicago. Un’operazione che mirava a contrastare e abbattere l’influenza della “New Left” negli ambienti accademici e che apriva la strada alle teorie neoliberiste di Milton Friedman, mentre in Italia, Federico Caffè, “l’ultimo baluardo” del keynesismo Italiano ammoniva il PCI sulle scelte di politica economica operate dal partito nel corso degli anni ’70 che, al tramonto del XX secolo, fecero colare a picco l’obiettivo economico-sociale dei costituenti e quanto fu sostenuto in sede di assemblea costituente dal demolaburista Meuccio Ruini, il quale replicando a Luigi Einaudi e alle ipotesi di “terza via”, disse: “Non pochi vanno affannosamente alla ricerca della terza strada. La troveranno? Non lo so. Questo so: che si avanza la forza storica del lavoro.”[2]
Nel contesto operativo della strategia portata avanti dai “Chicago boys”, le cui consulenze economiche furono particolarmente gradite al Cile di Pinochet, era necessario procedere al reclutamento di esponenti delle forze avversarie che, nell’arena agonistica della socialdemocrazia, portavano avanti le istanze della classe lavoratrice, e indebolire i residui retaggi di keynesismo nei partiti di centro-sinistra, per cui se negli States Jimmy Carter riteneva inopportuno l’intervento pubblico ai fini della risoluzione dei problemi sociali, dall’altro lato, la “Lady di ferro”, Margaret Thatcher, poteva tranquillamente sostenere che il suo più grande successo era il “New Labour” di Tony Blair. In effetti, ciò che accadde alle “sinistre” del mondo occidentale, si può spiegare alla luce dell’applicazione di un antico stratagemma bellico cinese: “Se vuoi fare qualcosa, fa in modo che il tuo avversario lo faccia per te (ovvero uccidere con una spada presa a prestito)”.
Il libro di Marco d’Eramo, dunque, ci spiega che i marines studiano l’ideologia e la sua forza rappresentativa e narrativa, mentre nelle sedi dei partiti riformisti e negli ambienti del ceto artistico-intellettuale del nostro Paese (ma non solo, ovviamente) il solo riferimento al vocabolario di classe, tanto in voga nel ‘900, e al suo tentativo impervio di contestualizzazione alla post-modernità, fa piovere accuse di paleo-socialismo su chi si azzarda a utilizzare le categorie del pensiero marxiano, socialista o cattolico-sociale in senso ampio, perché si sa: alla fine conveniva buttare via l’acqua sporca col bambino. Dunque, serviva un nuovo linguaggio culturale che riflettesse l’aziendalizzazione dei vari rami dell’amministrazione pubblica e che, attraverso anglicismi e neologismi mettesse in evidenza le nuove necessità da parte degli organismi pubblici di essere competitivi e all’altezza della sfida globale, e servivano i toni fatalistici utili a corroborare il sentimento di ineluttabilità dell’unico mondo unito dalle complesse reti di connessione economica. Il campo della politica viene così egemonizzato dalle logiche mercatistiche, tanto che come osservava acutamente Lasch “I partiti politici sono ormai specializzati nel pubblicizzare e vendere i loro uomini perché il pubblico li consumi, e persino la disciplina di partito si è gravemente allentata”[3] e ciò determina nuove modalità operative fondate sulle indagini di mercato atte a registrare, manipolare e banalizzare le opinioni del consumatore-elettore.
Di fronte alla lucida analisi retrospettiva dell’autore di “Dominio”, alla descrizione della trasformazione dei rapporti di forza e alla finanziarizzazione dell’economia che acuiscono la loro accelerazione in tempi pandemici (la “guerra invisibile” di cui parla l’autore), il discorso politico attende con la consueta lentezza una riorganizzazione delle forze popolari private delle loro “élite”, sapientemente reclutate al fine di aumentare la potenza di fuoco dei dominanti, i quali sanno dell’importanza strategica di creare vuoti e spazi invisibili. Invero, sanno dell’importanza delle parole e del silenzio, della guerra visibile e di quella invisibile e sanno cogliere il suggerimento che arriva dalla storia, ovvero sanno perfettamente che, come direbbe il re di Prussia Federico il Grande, “il cittadino non deve accorgersi che il re fa la guerra”. L’invisibilità e la proiezione inconscia degli schemi ideologici neolib sono quindi stati il “cavallo di Troia” delle nuove élite globaliste (“gli americani hanno colonizzato il nostro subconscio” direbbe uno dei protagonisti del film “Nel corso del tempo” di Wim Wenders) che agevolmente hanno potuto introiettare l’idea del credito al consumo, dei mutui trentennali e dell’uomo in quanto capitale umano che rivendica a sé il titolo di proprietà.
Un lavoro certosino di ripescaggio delle idee, che correttamente l’autore definisce “armi”, citando William Simon, non può restare indifferente alla capacità dei dominanti di creare una strategia “leninista” a sostegno dei loro interessi di classe, perché è solo in questo modo che ci si avvede della funzione della cultura in chiave contro-egemonica e della sua capacità di elaborare nuove frontiere di competizione politica e un nuovo immaginario simbolico a connotazione marcatamente popolare. D’altronde se è possibile scegliere diversamente dal dominio della libertà, allora è possibile essere eretici (dal greco “haìresis” che significa scelta) fino ad allora, per citare il Signor G, “ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà”[4].
[1] Marco D’Eramo, “Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi”, cit., p. 57
[2] Meuccio Ruini, Discussione generale del progetto di Costituzione della Repubblica Italiana, 12 Marzo 1947
[3] Christopher Lasch, “L’io minimo, Politica come consumo”, cit., p. 32
[4] Giorgio Gaber, “L’America” dall’album “E pensare che c’era il pensiero”
